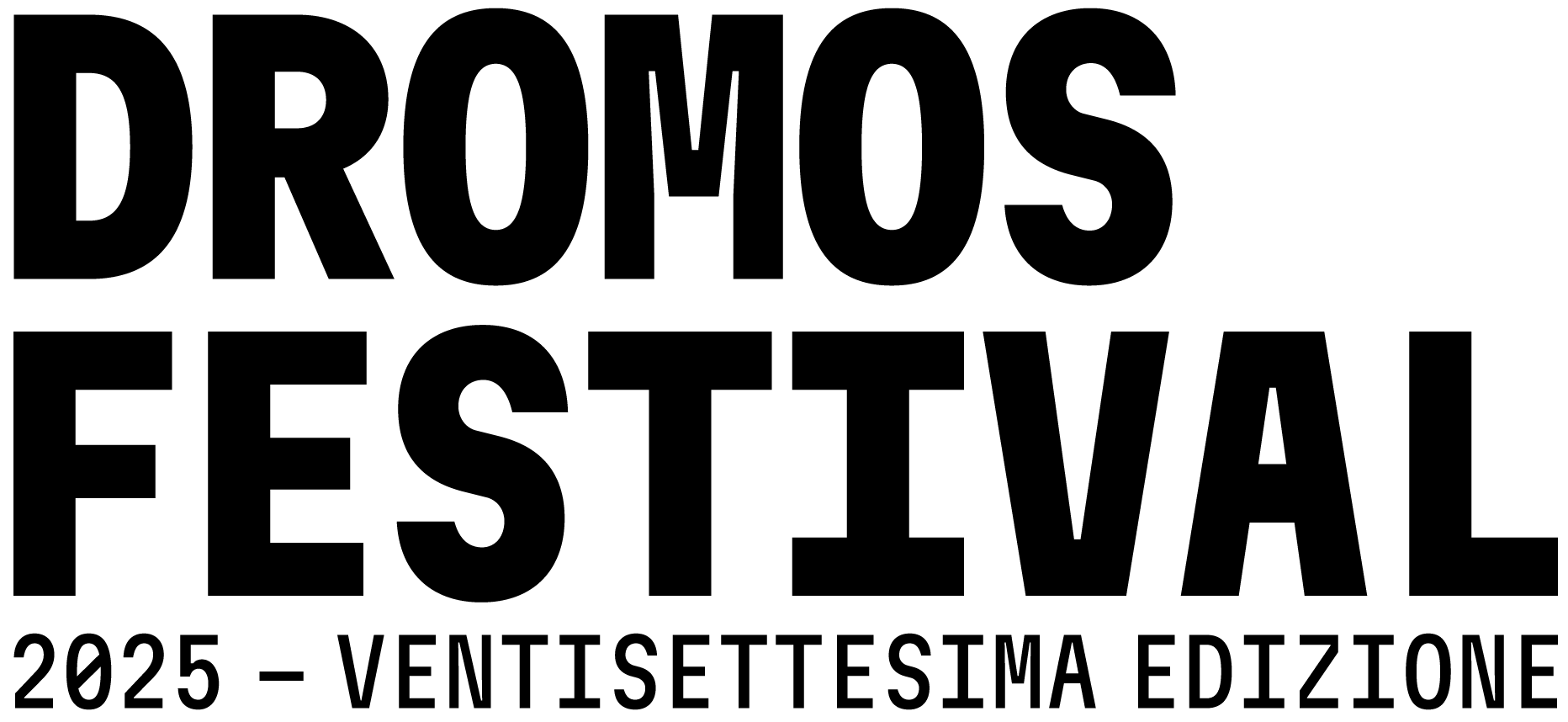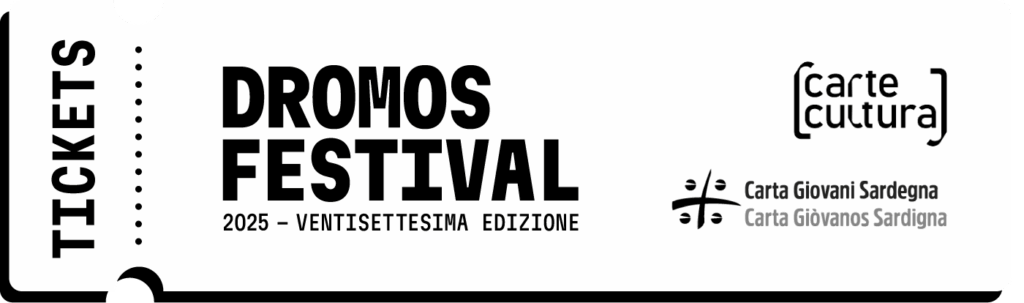HOPE
Se non sentiamo la speranza è il momento di crearla.
(Daisaku Ikeda)
Le domande più profonde che l’uomo da sempre si è posto riguardano il senso della vita, la storia dell’umanità e l’universo. Quesiti che ineluttabilmente si incrociano e fanno i conti con i tempi moderni saturi di brutalità e indifferenza verso il prossimo. Ancora più oscuro appare lo scopo del nostro esistere a cui mai, neppure la scienza, è riuscita a dare risposte compiute, e a cui la filosofia ha contribuito, com’è suo compito fare, ad alimentare, semmai, il numero dei dubbi. L’uomo si ritrova, perciò, obbligato a scegliere, nel suo incedere verso il futuro, tra l’apparente assurdità del corso degli eventi e la speranza.
Per chi, come Dromos, si impegna nella costruzione di un mondo solidale, giusto e nonviolento, parole come umanità, cambiamento e speranza, costituiscono, del resto, indagine costante del suo percorso. Già potenti se considerati singolarmente, questi concetti, in sinergia tra loro, diventano una miscela esplosiva capace di orientare l’uomo verso una reale inversione di rotta. E se nelle ultime due edizioni, con People e Change. Puoi, il Festival ha proposto una visione combinata e inscindibile tra l’uomo e il cambiamento, scegliendo HOPE per l’edizione 2025, Dromos intreccia e connette la Speranza ai due temi precedenti, ponendola come strumento impareggiabile e prezioso per sigillare questa triade e guardare con fiducia verso il futuro. Argomento, quello in programmazione, che lungi dal chiudere l’importante percorso portato avanti in questi anni, indirizza e proietta verso lo sviluppo di una cultura equa e costruttiva, realizzabile solo con la partecipazione attiva e intenzionale di ognuno di noi.
Umanità e speranza sono, d’altronde, concetti concatenati che si potenziano a vicenda: sentirsi parte del cosmo, collegati agli altri esseri umani e a tutti gli organismi viventi, rappresenta il fondamento delle imprese più evolute che l’uomo ha compiuto nel corso della storia. I pensieri e le gesta di saggi, sapienti e attivisti per la pace, mai vinti dall’ingiustizia e dalla violenza, costituiscono un capitale inestimabile di altruismo e clemenza da cui attingere speranza. Nutrirla, in questo tempo disumano e conflittuale, si rivela, dunque, come la più rapida e insidiosa risposta alla tirannia del terrore e all’imperativo della rassegnazione. HOPE si pone, in questo senso, come irrinunciabile spinta che apre all’avvenire e incentiva all’azione, va oltre l’illusione e la pigrizia mentale, habitus virtuoso che tende verso un bene possibile anche se difficile da raggiungere. Costituisce, per dirla con una frase attribuita ad Aristotele, il sogno di un uomo sveglio: non impeto arido e rassegnato ma linfa capace di nutrire il desiderio, forza epidemica al servizio dell’umanità, antidoto allo scoramento e all’apatia, messa a fuoco dei propri sogni e obiettivi alla ricerca del modo migliore per raggiungerli.
Si narra che durante la colonizzazione dell’America Latina, una volta imprigionati dai conquistadores, gli indios si lasciassero morire d’inedia. Le popolazioni indigene discendevano da civiltà arcaiche che si limitavano a vivere nel presente, e per questo in loro non esisteva alcuna consapevolezza del futuro. Convinti che la loro condizione di prigionieri sarebbe durata per sempre, senza alcuna speranza che alimentasse l’impegno di un possibile cambiamento, semplicemente si spegnevano. La speranza sembra necessitare, dunque, di un aspetto fondamentale: la capacità di immaginare l’avvenire e l’abilità di ideare, per quanto possibile, soluzioni che possano condurre al conseguimento di quanto sperato. Come afferma la filosofa spagnola Maria Zambrano, essa è ponte, impulso che ci destina all’ulteriorità, a uscire da ciò che ci imprigiona e incatena. È la voglia di continuare a esistere, a esistere al meglio, anche in un clima e in un regime di incertezza. Goethe la raffigura come un essere alato che trascende il tempo alla ricerca della visione di possibili futuri. Librarsi oltre il presente consentirebbe di individuare strade nuove da intraprendere, inesplorate ma percorribili, poiché il futuro prima si prefigura e poi si crea, e ciò che esiste nel presente non è altro che il risultato della speranza del passato. Allo stesso modo, ciò che con la speranza riusciamo a immaginare oggi, dischiude al futuro di domani.
Daisaku Ikeda la pone, senza indugio, come essenziale nella vita di ogni essere vivente. Per lo scrittore, attivista e maestro buddista, essa non è espressione dell’insoddisfazione del presente rispetto alla soddisfazione del futuro atteso con fiducia, ma espressione della pienezza del presente, un presente ravvivato da una sensazione del possibile. Adottarla come filosofia di vita, anche se le condizioni presenti sono ottimali, ci renderebbe tutti più felici, visione in grado di trasformare lo sconforto in quel potenziale infinito che esiste in ogni uomo. Per questo: se non sentiamo la speranza è il momento di crearla.
Chiara Schirru
SCENOGRAFIA a cura di Mattia Enna
SALTIMBANCHI MOSTRINÆ
Quando l’uomo decide di denudarsi, esponendosi con la sua genuinità fatta di pregi,
difetti e debolezze, entra in sintonia con il mondo. Mostra così la sua anima, diventando
un Mostrinæ saltimbanco: un essere unico, irripetibile e, a suo modo, bellissimo, che
acquisisce così il diritto di stare al centro dell’attenzione, di diventare il fulcro dello
spettacolo.
Ci saranno quindi ventidue piedistalli, ma solo alcuni saranno occupati da un
Mostrinæ, gli altri saranno vuoti, nella speranza che, tra il pubblico, qualcuno decida di
abbandonare le sue sovrastrutture diventando anch’esso, idealmente, un saltimbanco.